 Dott. Giuseppe Marino - specialista in ricorsi
tributari - www.studiomarino.com
orari d'ufficio 9.30-12.30 e 15.30-18.30
Dott. Giuseppe Marino - specialista in ricorsi
tributari - www.studiomarino.com
orari d'ufficio 9.30-12.30 e 15.30-18.30
 Dott. Giuseppe Marino - specialista in ricorsi
tributari - www.studiomarino.com
orari d'ufficio 9.30-12.30 e 15.30-18.30
Dott. Giuseppe Marino - specialista in ricorsi
tributari - www.studiomarino.com
orari d'ufficio 9.30-12.30 e 15.30-18.30
![]()
 081/5706339
081/5706339
 081/0060351
081/0060351
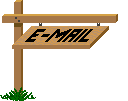 E-Mail
Consulenza a
pagamento
E-Mail
Consulenza a
pagamento

![]()
![]()
Somministrazione di lavoro e intermediazione di manodopera
La Corte di cassazione, sezione penale, con sentenza n. 2583/2004, si pronuncia per la prima volta in tema di somministrazione di lavoro e intermediazione di manodopera e, in particolare, sul regime sanzionatorio, tra il Dlgs n. 276/2003 di attuazione della Riforma Biagi e vecchia normativa
Con sentenza n. 2583 del 26 gennaio 2004, la terza sezione penale della Corte di cassazione ha preso posizione in ordine all'intervenuta abrogazione della legge n. 1369/1960 a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs n. 276/2003.
Pur riconoscendo il superamento del monopolio pubblico del collocamento, già avviato con la legge n. 196/1997 e l'art. 10 del Dlgs n. 469/1997, la Corte di cassazione ha parlato di abrogatio sine abolitione, ovvero ha ritenuto che l'illecita mediazione nella fornitura di manodopera punita dall'art. 27 della legge n. 264/1949 è stata solo parzialmente abrogata dalla fattispecie di esercizio abusivo della intermediazione di cui all'art. 18, comma 1, secondo e terzo periodo, del Dlgs n. 276/2003, con conseguente applicazione della normativa più favorevole ex art. 2, comma 3 c.p. (cfr. altresì Cass., S.U. n. 25887 del 16 giugno 2003 in materia di continuità normativa). Lo stesso ragionamento è stato seguito in ordine alla fattispecie penale già contemplata dagli artt. 1 e 2, legge 1369/1960 in relazione a quella introdotta dall'art. 18, comma 1, primo periodo, e comma 2, primo periodo, Dlgs n. 276/2003, ritenendo che ogni volta in cui un imprenditore utilizzi prestazioni di lavoro fornite da altri, assumendosi tuttavia l'organizzazione dei mezzi, la direzione dei lavoratori ed il rischio d'impresa, si concretizza una somministrazione di manodopera che resta vietata e penalmente sanzionata se priva dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti dal Dlgs n. 276/2003. In buona sostanza, ciò che era sanzionato dalla precedente normativa come appalto di mere prestazioni di lavoro, è ora qualificato come somministrazione di lavoro e, indipendentemente dal nomen iuris del contratto, è ugualmente punito se esercitato da soggetti non abilitati o fuori dalle ipotesi previste dalla nuova legge o, comunque, fraudolentemente (art. 28), ossia con il fine di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo.
|
Così la decisione della Corte di cassazione |
|
CASS., SEZ. 3A PEN., 26 GENNAIO 2004, N. 2583 Pres. Raimondi; Est. Onorato; P.M. (Conf.) Izzo; Ric. M. Lavoro - Intermediazione nella manodopera - Fatti punibili anche nel Dlgs n. 276/2003 - Condizioni La fattispecie di illecita mediazione nella fornitura di manodopera punita dall'art. 27 legge 29 aprile 1949 n. 264 è solo parzialmente abrogata dalla fattispecie di esercizio abusivo della intermediazione di cui all'art. 18, comma 1, secondo e terzo periodo, Dlgs n. 276/2003, in quanto i fatti di intermediazione commessi da soggetti privati non formalmente autorizzati, che erano punibili secondo la legge precedente, restano punibili anche nella nuova legge, con la conseguenza che si applicherà ad essi il principio della legge più favorevole di cui al comma 3 dell'art. 2 c.p., mentre altri fatti di intermediazione, che sono diventati legittimi con il Dlgs n. 276/2003, restano fuori della nuova fattispecie incriminatrice e non possono essere puniti neppure se commessi sotto il vigore della vecchia norma abrogata. Lavoro - Somministrazione illecita di lavoro - Appalto di mere prestazioni di lavoro - Fatti punibili nel Dlgs n. 276/2003 - Condizioni La fattispecie di appalto di mere prestazioni di lavoro punita dall'art. 1, comma 3, legge 23 ottobre 1960 n. 1369 è solo parzialmente abrogata dalla fattispecie di somministrazione di lavoro esercitata da soggetti non abilitati o fuori dei casi previsti punita dall'art. 18, comma 1, primo periodo, e comma 2, primo periodo, Dlgs n. 276/2003, in quanto solo alcuni fatti puniti dalla legge abrogata non costituiscono più reato secondo la legge sopravvenuta (le somministrazioni di lavoro da parte di agenzie private abilitate e nei casi consentiti), mentre altri fatti continuano ad essere puniti come reato (le somministrazioni di lavoro da parte di soggetti non abilitati o fuori dei casi consentiti, che la legge abrogata puniva come appalti di mere prestazioni di lavoro). |
I precedenti
E' da rimarcare che la decisione della Corte di cassazione in esame giunge a brevissima distanza, in ordine di tempo, dalla sentenza n. 571/2003 del Tribunale penale di Ferrara (in Guida al Lavoro n. 5/2004, pag. 12), con la quale il Giudice di merito aveva, al contrario, escluso l'applicazione della normativa in tema di successione di leggi penali nel tempo, ritenendo che le due fattispecie incriminatrici (art. 1, legge n. 1369/1960 e art. 18, Dlgs n. 276/2003) fossero diverse in quanto gli elementi che ne integrano la tipicità risulterebbero eterogenei, fatto salvo, ovviamente, l'interesse del lavoratore a richiedere l'inquadramento alle dipendenze della ditta committente. La nuova normativa infatti, secondo il Tribunale di Ferrara, non attribuirebbe disvalore in sé all'istituto della somministrazione, richiedendo unicamente dei requisiti oggettivi per la sua legittimità.
L'articolo 18, ultimo comma, del Dlgs n. 276/2003 stabilisce, tuttavia, che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni il Ministro del lavoro e delle politiche sociali deve disporre, con proprio decreto, criteri interpretativi certi per la definizione delle varie forme di contenzioso in atto riferite al pregresso regime in materia di intermediazione e interposizione nei rapporti di lavoro.
Osservazioni conclusive
Tanto nella vicenda giudiziaria oggetto della citata decisione del Tribunale di Ferrara quanto in quella oggetto della decisione del Giudice di legittimità che qui si commenta, gli imputati sono stati assolti.
Tuttavia, nel primo caso l'assoluzione è dovuta all'intervenuta abrogazione del reato in questione, che per il giudice di merito riveste carattere sostanziale, mentre nel secondo caso la Corte di cassazione ha ritenuto di assolvere l'imputato in quanto, nella fattispecie oggetto d'esame, i fatti accertati non integravano gli estremi del reato, pur confermando in linea di principio la punibilità del reato di intermediazione di manodopera così come rinovellato dal legislatore.
Trattandosi, pertanto, di abrogazione formale e non sostanziale, per fatti commessi anteriormente alla suddetta abrogazione, in virtù dell'orientamento assunto dalla cassazione dovranno applicarsi i principi in tema di successione di leggi penali nel tempo ovvero dovrà applicarsi la disciplina più favorevole, individuata in quella contemplata dal Dlgs n. 276/2003.
Trf termini di pagamento
La Corte di cassazione , con sentenza n. 1040/2002, ribadendo che il diritto al trattamento di fine rapporto sorge in capo al lavoratore al momento della cessazione del rapporto, afferma che il datore di lavoro il quale salvo clausola del Ccnl che prevede dilazioni di pagamento paghi tutto il Tfr in un momento successivo alla stessa, è comunque tenuto alla corresponsione di interessi e rivalutazione con decorrenza dalla cessazione
La sentenza della Corte di cassazione in commento la quale ha esaminato il caso di un lavoratore che, percepito il trattamento di fine rapporto trascorsi quarantacinque giorni dalla cessazione dal servizio, ha richiesto interessi e rivalutazione per il periodo di ritardo fornisce risposta chiara alla domanda che molto spesso si pongono gli operatori nel momento in cui devono liquidare il trattamento di fine rapporto.
La domanda è la seguente: il trattamento di fine rapporto (Tfr) deve essere pagato immediatamente alla cessazione del rapporto di lavoro oppure si può differirne il pagamento di un certo periodo (uno/due mesi), in relazione al tempo normalmente occorrente al datore di lavoro per effettuare i calcoli nonché alla necessità di attendere la pubblicazione degli indici Istat per conteggiare esattamente la rivalutazione dell'ultimo accantonamento?
La risposta della Corte di cassazione è, in sintesi, così articolata:
- il trattamento di fine rapporto deve esser pagato immediatamente alla cessazione del rapporto di lavoro;
- accade che il calcolo della rivalutazione dell'ultimo accantonamento del trattamento di fine rapporto non possa essere effettuato immediatamente alla cessazione del rapporto, per indisponibilità degli indici Istat.
E' solo in riferimento alle differenze connesse a questo calcolo che il datore di lavoro può differire il pagamento al momento della conoscenza dell'indice Istat; tutto il resto del trattamento, quindi, se non pagato immediatamente alla cessazione del rapporto, dà diritto al lavoratore di ottenere interessi e rivalutazione per il ritardo ex articolo 429 del codice di procedura civile (la sentenza della Corte di cassazione in commento non cita espressamente quest'ultima norma, il rinvio alla quale è da considerarsi implicito; richiama invece questa norma, in fattispecie analoga, Cass. 12 marzo 2001, n. 3563); nella contrattazione collettiva si rinvengono clausole che abilitano il datore di lavoro a differire il pagamento di tutto il trattamento di fine rapporto.
|
Così la decisione della cassazione |
|
CASS. SEZ. LAV. 28 GENNAIO 2002, N. 1040 Pres. Saggio; Rel. Spanò; P.M. Matera; Ric. Società Poligrafici Editoriale; Res. Passini Giancarlo Diritto al pagamento del trattamento di fine rapporto - Sorge alla cessazione del rapporto di lavoro - Ritardo nel pagamento in attesa degli indici Istat - Diritto del lavoratore ad interessi e rivalutazione: spetta - Clausole dei contratti collettivi Il fatto che alla cessazione del rapporto di lavoro non sia possibile al datore effettuare il calcolo completo della rivalutazione del Tfr, in quanto gli indici Istat relativi all'ultimo periodo non sono immediatamente disponibili, non lo legittima a ritardarne il pagamento ad un periodo posteriore alla cessazione del rapporto. Difatti, il diritto al pagamento del Tfr matura alla cessazione del rapporto ed a tale data deve essere pagato tutto il Tfr maturato: le differenze di rivalutazione, conseguenti alla pubblicazione degli indici Istat, potranno essere saldate successivamente, a conguaglio. Questo meccanismo di duplice pagamento a carico del datore di lavoro, anticipo e conguaglio, non contrasta né con l'art. 3 Cost. né con l'art. 41 Cost. Il datore di lavoro che, invece, come nella specie, paghi tutto il Tfr in ritardo è comunque tenuto al pagamento di interessi e rivalutazione con decorrenza dalla cessazione del rapporto. Peraltro, molti contratti collettivi (ma non quello applicabile alla fattispecie) prevedono dilazioni per il pagamento del Tfr. |
Il momento in cui sorge il diritto al pagamento del Tfr
Recita l'articolo 2120 del codice civile, prima parte: "in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto al trattamento di fine rapporto".
Al di là della ricostruzione dell'istituto del trattamento di fine rapporto, come diritto che matura di anno in anno perché annualmente accantonato, ovvero che matura alla cessazione del rapporto di lavoro, la dottrina è sempre stata concorde nell'affermare che il diritto al pagamento del trattamento di fine rapporto così come letteralmente si evince dalla disposizione sopra citata sorge al momento della cessazione del rapporto (cfr., per tutti, Santoro Passarelli, Il trattamento di fine rapporto, Giappichelli, Torino, 1995, pagg. 2729).
Anche i precedenti giurisprudenziali del Supremo Collegio hanno sempre posto in luce che il momento in cui viene in essere il diritto al pagamento del trattamento di fine rapporto è quello della "cessazione del rapporto" così come previsto espressamente dall'articolo 2120 cit. (così Cass. 18 agosto 2000, n. 10942).
Il Supremo Collegio (Cass. n. 10942/2000, cit.) ha anche chiarito che non vale, in contrario, argomentare che la difficoltà di calcolare il trattamento di fine rapporto al momento della cessazione del rapporto legittima il differimento del pagamento in applicazione dell'articolo 1183 del codice civile (il quale recita: "se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo od il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice..."): difatti alla cessazione del rapporto il credito per Tfr, seppure illiquido, perché non completamente determinato o determinabile, è comunque immediatamente esigibile (Cass. n. 10942/2000 cit.; in termini Cass. 3563/2001 cit.).
Un importante corollario di quanto sopra esposto è che la prescrizione del credito per trattamento di fine rapporto decorre dalla data di cessazione del rapporto. Difatti, ex articolo 2935 del codice civile, "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere" (cfr. Cass. n. 10942/2000 cit. e Cass. 18 novembre 1997, n. 11470).
L'altro importante corollario è che, qualora il trattamento di fine rapporto non sia pagato al momento della cessazione del rapporto, sono dovuti interessi e rivalutazione per il ritardo, ex articolo 429 del codice di procedura civile (Cass. 3563/2001 cit.), così come avviene per ogni credito del lavoratore non tempestivamente soddisfatto.
Anche un ritardo lieve fa sorgere il diritto del lavoratore al pagamento degli accessori, così come precisato dalla sentenza in commento, che ha condannato in tal senso l'azienda colpevole di avere corrisposto il trattamento di fine rapporto con ritardo di quarantacinque giorni.
Rivalutazione e conoscibilità degli indici Istat
La disciplina legale del trattamento di fine rapporto (art. 2120 del codice civile) dispone che gli accantonamenti effettuati di anno in anno devono essere rivalutati al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione della quota relativa all'anno in corso, mediante applicazione di un tasso composto.
Questo tasso composto è costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
Il meccanismo di rivalutazione tende, evidentemente, a compensare lo sganciamento del trattamento dall'ultima retribuzione percepita dal lavoratore.
Nel caso in cui il rapporto venga a cessare nel corso dell'anno, l'incremento dell'indice Istat è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello del dicembre dell'anno precedente, computandosi come mese intero le frazioni pari o superiori ai quindici giorni.
Ad esempio: se un dipendente cessa il servizio in data 8 febbraio 2002, gli spetterà oltre alla quota di Tfr accantonata per l'anno 2002 che non si rivaluta quanto accantonato fino al 31 dicembre 2001 rivalutato secondo il coefficiente (sopra indicato) desumibile dall'Istat applicabile al periodo di cessazione del rapporto, ossia il coefficiente di gennaio 2002 (va infatti rilevato che il rapporto a febbraio è rimasto in vita meno di quindici giorni, e perciò si applica il coefficiente del mese precedente).
Orbene, poiché l'Istat emette alla metà di ogni mese circa l'indice di aumento dell'indice dei prezzi al consumo (cfr. al riguardo il calendario dei comunicati stampa Istat in Guida al Lavoro n. 50/2001, pag. 11), anche il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto, che a detto indice Istat fa riferimento, è nella maggior parte dei casi conosciuto con ritardo, rispetto alla cessazione del rapporto, dal datore di lavoro.
Sicché, per restare all'esempio proposto, il coefficiente di gennaio 2002, che riguarda i rapporti cessati dal 15 gennaio 2002 al 15 febbraio 2002, è stato deliberato dall'Istat in data 22 febbraio 2002.
I datori di lavoro fanno proprio riferimento a questa difficoltà di immediata conoscibilità degli indici Istat per giustificare il differimento del pagamento di tutto il trattamento di fine rapporto al momento della loro ufficiale pubblicazione.
La sentenza della Corte di cassazione in commento (peraltro conformemente ai propri precedenti: cfr. Cass. n. 10942/ 2000 cit.) ha bollato categoricamente di illegittimità questa prassi.
Il ritardo nella conoscenza del coefficiente di rivalutazione giustifica soltanto il differimento del pagamento di quella parte di rivalutazione del trattamento di fine rapporto che non si può immediatamente calcolare, appunto, per la indisponibilità del coefficiente stesso: mentre tutto il resto del trattamento, che è subito conteggiabile, deve essere versato immediatamente alla cessazione del rapporto.
La sentenza in commento ha ritenuto anche che tale meccanismo non si ponga in contrasto con i precetti costituzionali, così come invece sostenuto dal datore di lavoro. Difatti l'onere del datore di lavoro di effettuare un duplice conteggio non contrasta con l'articolo 3 della Costituzione, in quanto non si vede perché il sacrificio del datore di lavoro dovrebbe essere più grave, sì da determinare un'ingiustificata disparità di trattamento, di quello del lavoratore costretto ad attendere il pagamento di un importo frutto di anni di lavoro, sovente già destinato a far fronte a pressanti necessità.
Neppure si spiega, afferma la Corte di cassazione, per quale motivo la libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione dovrebbe essere meglio protetta del diritto del lavoratore, anch'esso garantito dall'articolo della 36 Costituzione, a conseguire la giusta mercede.
La previsione nei contratti collettivi
Sulla legittimità delle clausole dei contratti collettivi che differiscono il termine legale di pagamento del trattamento di fine rapporto, la Corte di cassazione con la sentenza in esame, pur dando atto che nella fattispecie all'esame non esistevano clausole siffatte, rileva in modo un po' ambiguo (nel senso che non ne trae conseguenze precise) che alcuni contratti collettivi "prevedono dilazioni per il pagamento del trattamento di fine rapporto, collegate all'acquisizione dei dati Istat".
In merito si osserva che, comunque, ad avviso di chi scrive, una clausola che abilitasse, sic et simpliciter, il datore di lavoro a differire il pagamento del trattamento di fine rapporto in un momento successivo a quello previsto dalla legge (id est: la cessazione del rapporto di lavoro), si porrebbe in contrasto con la legge medesima.
Trattandosi di legge non derogabile dalle parti ciò comporterebbe la nullità della clausola contrattuale a favore dell'applicabilità della regola legale.
In questo senso si è già espresso chiaramente il Supremo Collegio: "ciò per la ragione assorbente che l'articolo 2120 del codice civile abilita la contrattazione collettiva ad incidere unicamente sulla determinazione del quantum debeatur (comma secondo), ma non sugli altri aspetti dell'istituto inderogabilmente regolati dalla legge, tra i quali resta compreso il momento di maturazione del credito, e quindi, di esigibilità dello stesso" (Cass. n. 10942/2000 cit.; conforme Cass. 15 novembre 1993, n. 11247; sull'inderogabilità del momento di maturazione del trattamento di fine rapporto stabilito dall'articolo 2120 del codice civile, cfr. anche Cass. n. 3563/2001 cit.).
Conclusioni
In definitiva, deve ritenersi corretto, alla luce della vigente normativa, quanto affermato dalla sentenza in commento.
Tuttavia non si può non rilevare come abbiano, dal punto di vista pratico, ragione i datori di lavoro che si lamentano di dovere procedere due volte alla liquidazione del Tfr: una alla cessazione del rapporto; una in sede di conguaglio, alla pubblicazione degli indici Istat.
Ora, se è vero che nella pratica la liquidazione differita di un mese o due di tutto il trattamento di fine rapporto non genera normalmente contenzioso da parte dei lavoratori, i quali difficilmente pongono in essere una controversia per ottenere interessi e rivalutazione, meglio sarebbe in ossequio a quel principio di semplificazione di cui tanto si discorre che il legislatore ponesse regole tali da consentire un'unica liquidazione del Tfr senza, naturalmente, penalizzare le esigenze di attualizzazione del credito del lavoratore.
Maltrattamento ai dipendenti
L'articolo 572 cp, recante "maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli", punisce anche il datore di lavoro che commette atti di violenza fisica e morale sui suoi dipendenti
La Corte di cassazione con la sentenza in epigrafe prende posizione, confermando peraltro la declaratoria di responsabilità pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano, sulla configurabilità del reato di maltrattamenti previsto dall'art. 572 c.p., in relazione ad atti di vessazione fisica e morale posti in essere da un capogruppo responsabile di zona per le vendite porta a porta di prodotti per la casa nei confronti di alcuni giovani sottoposti all'autorità dello stesso nello svolgimento della predetta attività lavorativa.
Prendendo, dunque, spunto dalla disamina del caso concreto, tale pronuncia offre ai giudici di legittimità anche l'occasione per svolgere alcune riflessioni di carattere generale sui presupposti applicativi del reato de quo con riferimento, appunto, a rapporti di dipendenza per motivi di lavoro.
|
Così la decisione della cassazione |
|
Cass. sez. pen. VI 12 marzo 2001, n. 10090 Pres. Sansone, Rel. Garribba, Ric. Erba Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli - Soggetto passivo del reato - Persona sottoposta ad autorità - Lavoratore dipendente - Situazione di subordinazione/sottomissione - Reato - Sussistenza Il rapporto intersoggettivo che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore subordinato, essendo caratterizzato dal potere direttivo e disciplinare che la legge attribuisce al datore nei confronti del lavoratore dipendente, pone quest'ultimo nella condizione specificamente prevista dall'articolo 572 c.p., di persona "sottoposta alla sua autorità"; il che, sussistendo gli altri elementi previsti dalla legge, permette di configurare a carico del datore di lavoro il reato di maltrattamenti in danno del lavoratore dipendente, là dove, esistendo tra le parti un'assidua comunanza di vita, le ripetute e sistematiche vessazioni fisiche e morali, riducano il lavoratore in uno stato di penosa sottomissione e umiliazione. |
Reato di maltrattamenti ex articolo 572 c.p.
Come è noto, infatti, il reato di maltrattamenti previsto dall'art. 572 c.p. esige per la sua configurabilità un'abituale sottoposizione della persona offesa a sofferenze fisiche e psichiche, espressione di un atteggiamento di normale prevaricazione da parte del soggetto attivo del reato nei confronti del soggetto passivo; ma richiede, altresì, che la condotta costitutiva del delitto si esprima fra persone legate da un rapporto particolare, del quale la caratteristica peculiare, individuabile con immediata certezza, è la soggezione di una parte nei confronti dell'altra o, almeno, la fiducia che il soggetto passivo ripone nel soggetto attivo. Deve trattarsi, in altre parole, come rilevato dalla dottrina, di un rapporto che, per essere appunto fondato sull'autorità e sulla fiducia e per essere destinato a una certa durata nel tempo, da un lato può favorire le manifestazioni di prepotenza del soggetto attivo e, dal lato opposto, può rendere non solo più penosa la sofferenza di quello passivo, ma anche più difficile a costui il sottrarsi alle predette vessazioni.
Al legislatore, in sintesi, interessa punire le degenerazioni di rapporti "qualificati", siano essi di famiglia, subordinazione o affidamento, quando sfocino in maltrattamenti inflitti dalla parte più forte a quella più debole, conferendo al fatto un disvalore del tutto particolare e giustificando, quindi, la previsione di una sanzione tutt'altro che esigua.
Invero, l'ipotesi di reato riconducibile alla fattispecie contestata di cui all'art. 572 c.p. di più frequente verificazione è senz'altro quella che dà il nome alla rubrica della norma in oggetto ("maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli"). Nondimeno, la succitata norma incriminatrice prevede, altresì, le ipotesi di chi commetta maltrattamenti in danno "di persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte". In questi ultimi casi, dunque, non è richiesta la coabitazione o convivenza tra il soggetto attivo e quello passivo, ma solo un rapporto continuativo dipendente da cause diverse da quella familiare. In tale prospettiva -osserva la Corte- "non vi è dubbio che il rapporto intersoggettivo che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore subordinato, essendo caratterizzato dal potere direttivo e disciplinare che la legge attribuisce al datore nei confronti del lavoratore dipendente, ponga quest'ultimo nella condizione specificamente prevista dall'art. 572 c.p., di persona "sottoposta alla sua autorità"; cosa che, in presenza degli altri elementi previsti dalla legge, permette di configurare a carico del datore di lavoro il reato di maltrattamenti in danno del lavoratore dipendente.
Conclusione, questa, tanto più fondata -ad avviso della Corte- nel caso di specie, se si considera che "il rapporto interpersonale che legava autore del reato e vittima era particolarmente intenso, poiché, a parte il contatto quotidiano dovuto a ragioni di lavoro, nel corso delle lunghe trasferte, viaggiando su un unico pulmino, consumando insieme i pasti e alloggiando nello stesso albergo, si realizzava tra le parti un'assidua comunanza di vita".
Aspetti giuslavoristici
La sussistenza del connotato della subordinazione -riconducibile all'art. 2094 del c.c. e intesa quale sottoposizione di un lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro- rappresenta la premessa necessaria per impostare l'analisi del caso che si commenta, ma non risulta certo sufficiente ai fini dell'inquadramento dogmatico completo della fattispecie "maltrattamenti in danno del lavoratore".
La trasformazione del lavoratore subordinato -inteso quale mero titolare di un rapporto di lavoro- in vittima di un reato di maltrattamenti, passa attraverso lo stravolgimento applicativo del parametro tradizionale di analisi giuslavoristica -la subordinazione appunto- fino alla sua trasformazione in qualcosa di diverso, meglio identificabile come penosa sottomissione e umiliazione.
La catena argomentativa costruita dai giudici di legittimità a partire dalla qualificazione giuridica del rapporto intersoggettivo esistente tra lavoratore e datore di lavoro -assiduo ed intenso rapporto di lavoro, quasi una comunanza di vita- arriva ad affermare l'esistenza di un vero e proprio "stato di soggezione personale" dei lavoratori. Lo scenario complessivo che la sentenza disvela comprende la descrizione precisa del comportamento datoriale -ricatti e vessazioni, fisiche e morali- e l'individuazione di una sua precisa finalità ultima -il tradizionale scopo di lucro- insieme alla specificazione delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che caratterizzano il reato specifico. Ci si limita a tal fine a segnalare, redigendo una sorta di breve elenco, la natura irregolare del lavoro svolto, il pagamento delle retribuzioni mediante versamento in libretti intestati ai lavoratori ma tenuti dal datore di lavoro, l'intensificazione ai limiti della sopportazione fisica dei ritmi di lavoro.
In tale contesto il richiamo effettuato dai giudici alle norme contenute nello Statuto dei lavoratori non può che svolgere una funzione di sostegno dell'affermazione del principio di tutela della dignità del lavoratore. Molto più interessante nell'economia della pronuncia l'utilizzo dell'art. 2087 del c.c. che ha consentito la condanna del titolare della ditta di vendita "porta a porta": "non impedire un evento che si ha l'obbligo di impedire", recita l'art. 40 del c.p. richiamato in motivazione, "equivale a cagionarlo". L'imprenditore in forza dell'articolo 2087 del codice civile è tenuto ad "adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro": omettendo di porre fine alle vessazioni attuate dai capigruppo sui lavoratori dipendenti, egli se ne rende corresponsabile.
Il binomio maltrattamenti - rapporto di lavoro non è certo una novità per giudici. Una breve rassegna delle pronunce emesse in passato comprende Cass., sez. VI, sentenza 24 settembre 1996 (in Giustizia Penale 1998, II, p. 84) emessa contro datori di lavoro di una persona extracomunitaria a cui non venne corrisposta retribuzione ed a cui sistematicamente fu imposto di non uscire, di non comunicare con alcuno, di lavarsi e vestirsi in giardino, di non guardare la televisione; e Trib. Milano, sentenza 2 luglio 1991, sentenza di assoluzione dei dirigenti dell'organizzazione Scientology sede di Milano - perché i fatti si svolsero a Copenaghen dove le persone in cerca di lavoro erano state sottoposte a ritmi di lavoro e di studio intensi, con retribuzione irrisoria, cibo scarso e sistemati in alloggi disagiati (in Diritto ecclesiastico, 1991, II, p. 419).